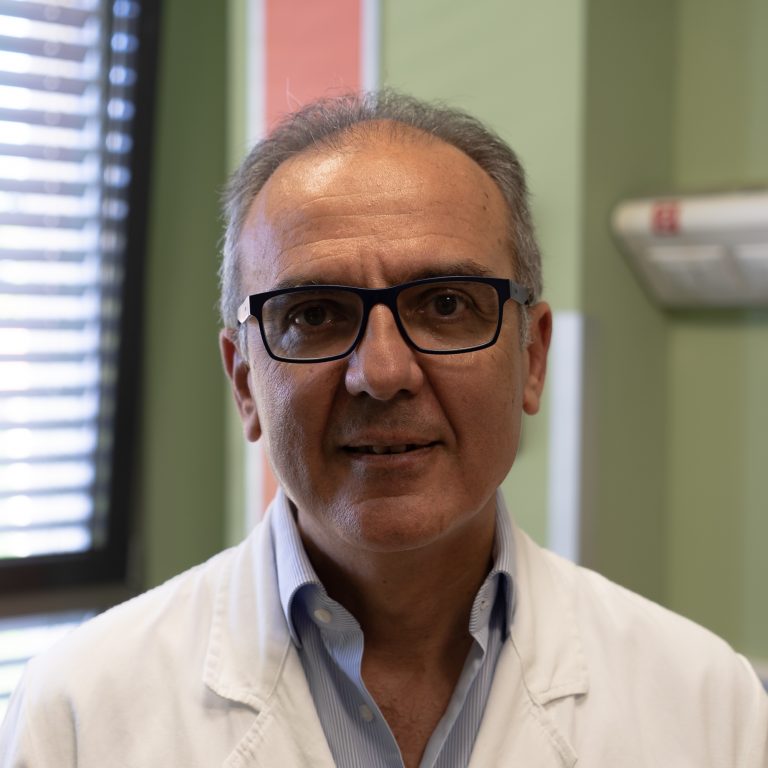Tuta, guanti, mascherina. Uno scafandro che da settimane è entrato nella nostra quotidianità come immagine e come abbigliamento da lavoro di tutti i giorni per medici, infermieri e operatori sanitari che stanno fronteggiando nei reparti l’emergenza Coronavirus.
«Ma ogni volta che ce li togliamo sembra che resti tutto addosso, insieme ai pensieri» racconta Marco, infermiere che per lavoro presta servizio in psichiatria ma che appena ha avuto la percezione dell’emergenza che stava per abbattersi anche sulla Toscana non ci ha pensato un attimo: «Ho contattato i miei superiori e ho dato disponibilità per essere trasferito per il periodo di emergenza a un reparto di area critica, o comunque dove ci sarebbe stato bisogno. A metà marzo mi hanno chiamato dicendomi che mi avrebbero mandato in un reparto ‘bolla’, la terapia intensiva Covid-19, se nel frattempo non ci avevo ripensato. Gli ho risposto che ero pronto».

Non è una scelta a cui Marco dà un valore particolare, anzi risulta quasi naturale. «Essere infermiere vuol dire scegliere di prendersi cura della collettività, mettersi a disposizione è nel dna di chi fa questo mestiere».
Il paragone con la guerra che si spreca in queste settimane, le metafore del ‘combattere il virus’ o di chi lavora ‘in prima linea’ forse sono non calzanti per dei professionisti che oltre all’epidemia devono fronteggiare anche il fattore tempo che non perdona mai. «Ho dovuto riprendere in mano un po’ di teoria che avevo studiato, cose che magari non avevo più fatto dal mio tirocinio durante il corso di studio. Ma queste settimane in reparto sono soprattutto un addestramento sempre in corsa, giorno dopo giorno. Imparo dai colleghi che sto supportando». Ma è dura anche per chi è abituato a lavorare in queste condizioni perché in condizioni normali il livello di gravità dei pazienti ricoverati è bilanciato in un reparto, adesso l’emergenza porta in quegli spazi solo situazioni al massimo grado di gravità.
Responsabilità, pressione, orgoglio. Sono i concetti che Marco spiega quando racconta queste giornate di lavoro: responsabilità «per le persone che assisto, per il team con cui lavoro, anche per tutta l’opinione pubblica che ogni giorno vuol sapere se negli ospedali la situazione sta migliorando o no»; pressione che si declina a volte in tensione «perché lavoro in un ambiente microbiologicamente saturo, sempre a rischio, mi trovo davanti persone che soffrono, non posso avere alcuna relazione con loro perché nel mio reparto i pazienti sono intubati e sedati», ma che porta anche orgoglio «quando sento che andare a lavoro mi dà la carica, che la gente che aspetta notizie conta idealmente su di me. Sentiamo la responsabilità, proviamo incertezze ma abbiamo la consapevolezza di quello che sappiamo fare».
Sensazioni che si mischiano alla paura «di essere un untore di chi mi sta vicino, parenti o vicini di casa per tutti i contatti che ho a lavoro. Per questo ho quasi interrotto i rapporti con tutto e tutti da qualche settimana, ma è una conseguenza che ho valutato nel momento in cui ho dato la disponibilità ad andare in reparto. Ma la paura fa nascere e alimenta il coraggio».
Tutte idee che facilmente si ammantano di retorica, quella che ci porta a definire ‘eroi’ o ‘angeli’ chi è faccia a faccia col virus. «Siamo sempre noi stessi» taglia corto Marco. «Quelli che venivano denunciati o aggrediti se un esame tardava o se un medico non poteva ricevere in tempi rapidi. Sì, è un modo per darci solidarietà ma io credo che sia più per esorcizzare una paura, fa bene allo spirito pensare a una specie di supereroe quando il nemico è così forte».
La mente a volte è il nemico più grande, venendo da psichiatria Marco sa che i rischi anche da quel punto di vista sono tanti: «Stiamo vivendo un periodo professionale che ci assorbe a livelli massimi, il rischio è che una volta a casa finito il turno il pensiero dominante sia sempre legato al lavoro, a quello che hai vissuto, a quello che vivrai il giorno dopo. Che diventi tutto un’attesa di rientrare in servizio».
Poi arriva il momento di staccare, di togliere tuta, mascherina e guanti. Tornare verso casa, dove in queste settimane «io e la mia compagna, anche lei infermiera, abbiamo fatto formazione alle persone del nostro condominio: spiegando comportamenti corretti soprattutto per anziani e bambini, fornendo gel per le mani».
Casa, con il reparto nella mente. Il reparto dove Marco una sera prima di staccare ha lasciato un foglio con una scritta di incoraggiamento accanto alla postazione di uno dei “suoi” pazienti: «Forza, non mollare». Non sa se l’abbia letta o meno, ma la considera come se fosse un passaggio di cura in più. Prendersi cura dell’animo di chi ci sta accanto in fondo è ciò che realmente ci farà uscire migliori da questa situazione.

 Giovanni Ciappelli
Giovanni Ciappelli